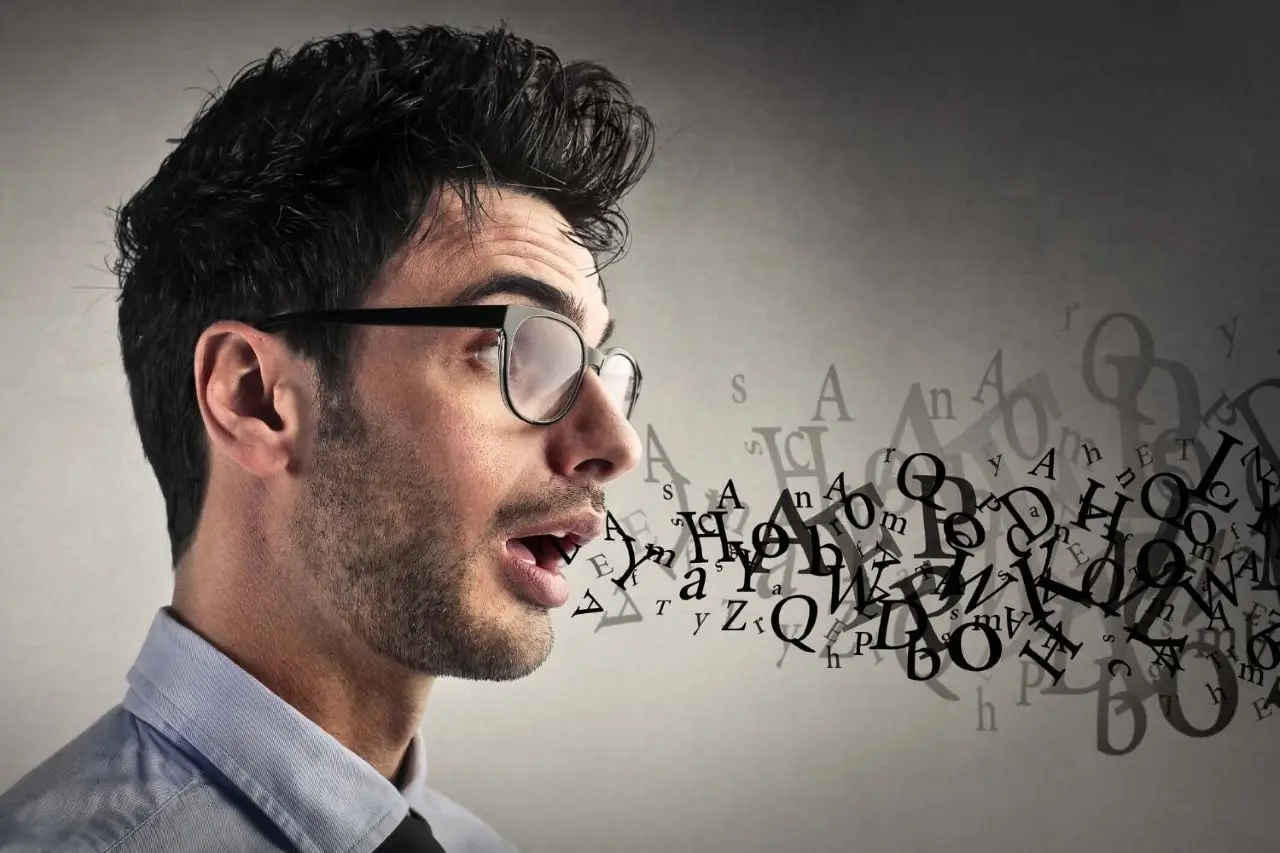Negli ultimi anni, l’attenzione delle autorità sanitarie e degli enti di controllo si è focalizzata in modo crescente sulla presenza di sostanze PFAS nei prodotti ittici. Questi composti chimici, noti per la loro straordinaria resistenza alla degradazione ambientale, sono stati individuati in numerose specie di pesci, crostacei e molluschi, suscitando notevoli preoccupazioni sia per la sicurezza alimentare sia per la salute pubblica. L’accumulo di PFAS negli organismi marini rappresenta infatti una minaccia concreta, in quanto queste sostanze possono entrare facilmente nella catena alimentare e raggiungere l’uomo attraverso il consumo di prodotti ittici contaminati.
Presenza di PFAS nei pesci, molluschi e crostacei
I PFAS, acronimo di sostanze perfluoroalchiliche, sono composti chimici impiegati in una vasta gamma di processi industriali e nella produzione di numerosi beni di consumo, grazie alle loro proprietà idrorepellenti e oleorepellenti. La loro straordinaria resistenza alla degradazione li rende particolarmente persistenti nell’ambiente: una volta dispersi, possono rimanere nei suoli, nelle acque e nei sedimenti per decenni o addirittura secoli, motivo per cui vengono comunemente definiti “inquinanti eterni”. La loro capacità di bioaccumulo e biomagnificazione li rende particolarmente pericolosi per gli ecosistemi acquatici e per la salute umana.

Numerosi studi e monitoraggi ambientali hanno documentato la presenza di PFAS nell’ambiente marino in diverse regioni italiane, con particolare attenzione a Veneto, Toscana ed Emilia Romagna. In queste aree, le analisi hanno evidenziato livelli di contaminazione preoccupanti in alcune specie ittiche, come cefali e crostacei, suggerendo una diffusione significativa di PFAS nelle acque costiere, nei corsi d’acqua e nei sedimenti. Questi dati sottolineano la necessità di un controllo costante e di interventi mirati per limitare l’esposizione della popolazione a tali sostanze.
Di conseguenza, la fauna marina risulta particolarmente esposta. Studi condotti a livello internazionale hanno riscontrato la presenza di PFAS in pesci comunemente consumati, come merluzzo, salmone e tonno, con concentrazioni particolarmente elevate nei crostacei. In Veneto, ad esempio, è stata individuata una vera e propria “area rossa” a causa dell’elevata esposizione ai PFAS, che interessa non solo le acque marine ma anche quelle destinate al consumo umano e domestico, aumentando il rischio per la salute della popolazione locale.
La conseguenze per la salute pubblica
Numerose ricerche scientifiche hanno ormai evidenziato le gravi conseguenze che l’esposizione ai PFAS può avere sulla salute umana. Questi composti sono in grado di interferire con il sistema endocrino, alterare i livelli di colesterolo nel sangue e aumentare il rischio di sviluppare patologie croniche, tra cui alcuni tipi di cancro e disfunzioni del sistema immunitario. I PFAS, inoltre, tendono ad accumularsi progressivamente nell’organismo umano, dove possono rimanere per lunghi periodi, aggravando i potenziali effetti negativi sulla salute.

Alcune categorie di persone risultano particolarmente vulnerabili agli effetti dei PFAS, come i bambini e le donne in gravidanza, per i quali l’esposizione può comportare rischi ancora più gravi e duraturi. L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha sottolineato che tra gli effetti più critici vi è la riduzione della risposta immunitaria, in particolare la diminuzione dei livelli di anticorpi prodotti in seguito alle vaccinazioni pediatriche, con conseguente maggiore suscettibilità alle infezioni.
Alcuni studi scientifici suggeriscono inoltre una possibile correlazione tra l’esposizione precoce ai PFAS e l’insorgenza di disturbi dello sviluppo neurocomportamentale, come deficit di attenzione, problemi cognitivi e alterazioni del comportamento nei bambini. Sono state ipotizzate anche associazioni con squilibri endocrini, in particolare per quanto riguarda la funzione tiroidea, che riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella crescita nei primi anni di vita.
Il ruolo delle autorità competenti
Il Ministero della Salute, in stretta collaborazione con le agenzie regionali per la protezione ambientale, ha rafforzato le attività di controllo e monitoraggio della presenza di PFAS nei prodotti ittici e nelle acque. Attraverso il Piano Nazionale per la Ricerca dei Residui, vengono effettuati regolarmente campionamenti e analisi per valutare il livello di contaminazione e garantire la sicurezza degli alimenti destinati al consumo umano.

Inoltre, il sistema rapido di allerta per alimenti e mangimi consente una tempestiva diffusione delle informazioni relative ai rischi per la salute derivanti da alimenti contaminati. Grazie a queste procedure, le autorità possono intervenire rapidamente per disporre il richiamo e il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi, riducendo così l’esposizione della popolazione a sostanze potenzialmente pericolose.
Le autorità competenti sono inoltre impegnate nella definizione di limiti normativi specifici per la presenza di PFAS negli alimenti, basandosi sulle evidenze scientifiche fornite dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. L’adozione di standard uniformi a livello europeo rappresenta un passo fondamentale per garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica e favorire la commercializzazione di alimenti sicuri in tutto il territorio dell’Unione.
Raccomandazione per i consumatori
Di fronte a questa problematica di grande rilevanza rappresentata dai PFAS, i consumatori sono chiamati ad adottare alcune precauzioni per ridurre l’esposizione a queste sostanze chimiche persistenti. È opportuno, ad esempio, limitare o evitare il consumo di pesci e prodotti ittici provenienti da aree note per l’elevata contaminazione da PFAS, seguendo le indicazioni e le raccomandazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti.

È consigliabile adottare una dieta varia, includendo diverse fonti proteiche e alternando il consumo di pesce con altre tipologie di alimenti. È importante prestare attenzione all’origine dei prodotti ittici acquistati, evitando quelli provenienti da zone a rischio di contaminazione da PFAS, per prevenire le possibili conseguenze negative sulla salute. La tendenza dei PFAS ad accumularsi nell’organismo umano, dovuta alla loro elevata persistenza ambientale, rappresenta infatti un fattore di rischio da non sottovalutare.
I PFAS, essendo composti che non si degradano facilmente, tendono a depositarsi nei tessuti biologici, in particolare nel fegato, nei reni e nel sangue, dove possono persistere anche per molti anni. L’esposizione prolungata a queste sostanze può determinare effetti negativi sul sistema endocrino e immunitario, alterazioni metaboliche e cardiovascolari, oltre ad aumentare il rischio di sviluppare patologie oncologiche. È quindi fondamentale adottare comportamenti consapevoli per tutelare la propria salute e quella della collettività.